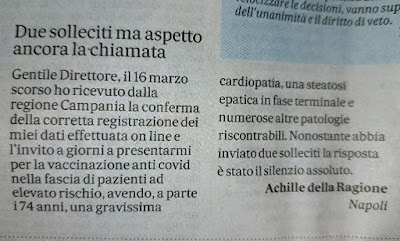|
| fig.1 - Scuola medica salernitana |
“Monsignore, voi schifate la mia arte, perché giovane e femina sono; ma io vi ricordo che io non medico colla mia scienzia, anzi collo aiuto d’Iddio e colla scienzia del maestro Gerardo nerbonese, il quale mio padre fu e famoso medico mentre visse” (Decameron).
Cominciamo con queste parole del Boccaccio e ciò che descriveremo è ambientato nel Basso Medioevo, un’epoca di ottimismo, di crescita economica, demografica e delle idee, quando sorsero le prime scuole di Medicina.
Non tutta l’Europa era cristiana, in Spagna comandava il Califfato. Il mondo arabo peraltro non era chiuso agli scambi culturali ed all’Occidente cristiano pervennero così le nozioni della medicina araba, a sua volta erede del Sapere del mondo antico.
La prima, e la più celebre istituzione che si interessasse di curare i malati, fu la Schola Medica Salernitana (fig.1), sulla cui origine non si sa molto.
Secondo la leggenda venne fondata da quattro dotti: un ebreo, un greco, un latino e un arabo (fig.2); in realtà i primi documenti che parlano della Scuola risalgono al X secolo, quando la città portuale di Salerno era importante già da cento anni, e i suoi medici già famosi: sappiamo che il re di Francia Carlo IV chiamò alla sua corte i medici di Salerno, ma accadeva anche che uomini d’élite si recassero di persona in città per farsi curare.
“Se vuoi vivere sano e senza malattie, schiva gli affanni e guardati dall’ira, bevi e mangia moderatamente, e dopo i pasti alzati subito da tavola e non fare il pisolino pomeridiano, non trattenerti dall’urinare e dall’andar di corpo…” (Regimen Sanitatis).
La Scuola aveva una connotazione laica, i Magistri Salernitani erano disposti a insegnare l’arte a chiunque desiderasse impararla. E per apprendere la Medicina ci volevano lungo tempo e tanto studio: a volte, noi “moderni” siamo quasi tentati di pensare che, siccome le loro teorie non avevano fondamento scientifico, allora fosse facile essere un medico. Invece si trattava di una scienza complessa, e la dimostrazione ci è data dai numerosi scritti (in latino) che la Scuola Salernitana (fig.3) ci ha lasciato.
E proprio i testi permettono di aprire una parentesi su un misterioso personaggio della Scuola: Trotula de’ Ruggiero, la celebre medica a cui sono attribuiti i trattati “De passionibus mulierum” e “De ornatu mulierum”, su argomenti di medicina e cosmesi della donna… Un personaggio che affonda più nella leggenda che nella Storia, forse. Sappiamo che nella Scuola furono attive diverse donne, le Mulieres Magistrae Salernitanae, ed effettivamente è segnalata una guaritrice di nome Trota (o Trocta), autrice di almeno un manoscritto; la conclusione a cui sono pervenuti gli storici è che il nome Trotula non indicasse un’autrice, ma il titolo di un corpus a cui avevano partecipato diverse persone (fig.4).
A prescindere dall’identità degli autori – o delle autrici – il contenuto di questi manoscritti è illuminante sulle conoscenze e le priorità che la Scuola si poneva.
“Inoltre, le donne, dalla condizione della loro fragilità, a causa di vergogna e d’imbarazzo, non osano rivelare la loro angoscia per le loro malattie (le quali accadono in un luogo così privato) a un medico” (La Trotula).
 |
| fig.2 - I 4 dotti della scuola medica salernitana |
 |
| fig.3 - Logo Universitá di Salerno |
 |
| fig.4 - Libro di Trotula |
La nascita dell’Ostetricia e della Ginecologia
Il medico o la medica che aveva studiato a Salerno sapeva, per esempio, che è essenziale che il flusso mestruale sia equilibrato – non deve essere troppo, ma neanche del tutto assente. Sapeva che a seguito del parto “a causa dell’indebolimento dei legamenti” può verificarsi un prolasso uterino e, oltre a riequilibrare gli umori, doveva provvedere a risistemarlo manualmente nella sua posizione. Preparava dei rimedi per disturbi imbarazzanti e fastidiosi come il prurito vaginale…
“Se vi è prurito nella vagina prendi canforo, litargirio, bacche di alloro e albume d’uovo, e fanne un pessario…”
I testi medici parlano anche della difficoltà a concepire, teorizzando, giustamente, che l’infertilità di una coppia talvolta sia dovuta all’uomo. Parlano delle difficoltà del parto; poiché è importante che il bambino cominci a uscire “di testa”, se invece spuntano fuori le gambe o le braccia allora va risistemato nella posizione corretta; si prescrivono rimedi per affrettare l’espulsione della placenta; e si discute di cosa fare nel caso il parto abbia lacerato il pavimento pelvico.
“Vi sono donne infatti presso le quali la vagina e l’ano diventano un unico orifizio e uno stesso canale. […] Assistiamo queste donne riposizionando la matrice. […] Successivamente, cuciamo la lacerazione tra l’ano e la vagina in tre o quattro punti con del filo di seta. […] E guariremo la lacerazione con una polvere fatta di consolida maggiore, ovvero di consolida e margheritina, e cumino.
La Scuola Medica Salernitana “contro” il modello patriarcale
Ma gli scritti della Scuola Salernitana sono straordinari perché si pongono tutta una serie di problemi che sfidano il modello patriarcale di società.
Laddove il valore di una ragazzina stava nella sua verginità, a Salerno si insegnava come preparare un buon costrittore per la vagina che simulasse la verginità.
Ci si preoccupava di aiutare quelle donne che soffrivano perché avrebbero desiderato avere rapporti sessuali, ma non potevano, avendo magari fatto voto di castità (fig.5). Oppure, i medici tenevano in conto che una donna non volesse più avere figli:
“Se la donna è stata malamente lacerata durante il parto e, in seguito, per paura di morire, non desidera più concepire, lascia che ponga nella placenta tanti semi di catapuzia o di orzo nel numero degli anni per i quali desidera restare sterile.”
Accanto a questi rimedi le donne del tempo potevano avvantaggiarsi di tanti piccoli accorgimenti per la loro bellezza: per rinfrescare l’alito cattivo, per migliorare il colorito o per colorare i capelli.
“Prendi rose secche, chiodi di garofano, noce moscata, crescione d’acqua e galanga maggiore. Lascia che tutti questi, una volta ridotti in polvere, vengano mescolati con acqua di rose. Con quest’acqua vi spruzzi i capelli e li pettini con un pettine imbevuto nella stessa acqua, così che avranno un profumo migliore.”
 |
fig.5 - Ragazza vergine,
illustrazione dal Trotula major |
Terapie nella Scuola Medica Salernitana
I medici ricorrevano ovviamente al salasso (fig.6), per trattare certi disturbi, e confezionavano farmaci i quali contenevano un gran numero di principi vegetali, senza disdegnare i minerali e i metalli, usati con grande libertà.
“Non c’era mercurio, né ossido di piombo, né zolfo, né borace, né cerussa, né olio di tartaro, nessun unguento che purifichi e bruci, che potesse alleviargli le bianche pustole e i vespai troneggianti sulle sue guance” (Racconti di Canterbury).
A Salerno, sotto il regno Normanno prima, e quello Svevo poi, la vita per i ciarlatani divenne molto più difficile. Per poter esercitare la professione bisognava ottenere un diploma sostenendo un esame di fronte al Collegio Medico di Salerno. Se vi interessa, per passare l’esame si doveva conoscere e saper commentare gli aforismi di Ippocrate; il primo libro di Avicenna e l’opera di Galeno.
 |
fig. 6 - Salasso
|
La pratica della chirurgia
Bene, le fonti ci dicono che veniva praticata. Sulla chirurgia del Medioevo sono state scritte cose contrastanti: è stato detto che il chirurgo fosse il parente povero del medico, che il medico conosceva il latino e la chirurgia veniva praticata da chi non aveva studiato; da barbieri, norcini e conciaossa. I cerusici facevano quello che i medici dotti non volevano fare, perché rischiosissimo a causa delle emorragie, della mancanza di norme di antisepsi, di anestesia.
Questo è in parte vero, ma non del tutto. Citiamo il caso di Rogerio Frugardi (XII secolo), il quale esercitò presso la Scuola Salernitana e scrisse un notevole trattato di chirurgia, la Practica Chirurgiae, intorno al 1170.
Il trattato, scritto con uno stile asciutto e pratico, descrive operazioni delicate come la trapanazione del cranio, la chirurgia dei traumi dell’addome e l’asportazione di tumori; si menziona la spongia somnifera, nota già agli Antichi Romani, che essendo imbevuta di sostanze come l’oppio alterava la percezione del dolore, rendendo l’intervento un po’ meno atroce per i pazienti. L’unica cosa che può lasciare perplessi è che si basava su studi anatomici condotti sul maiale.
Degna di nota è anche l’opera di Rolando da Parma (XIII secolo), il quale descrisse l’operazione dell’ernia nella posizione di Trendelenburg, cioè con i piedi in alto e la testa in giù.
Quindi i chirurghi studiavano?
Pare proprio di sì! L’imperatore Federico II di Svevia ordinò che i chirurghi, per esercitare, dovessero aver seguito lezioni di anatomia e aver studiato chirurgia per un anno. Lo stesso Federico II fu colui che trasformò la Schola Medica Salernitana in una istituzione pubblica. Ma fu colui che, ad un certo punto, le assestò una stilettata.
Egli fondò nel 1224 l’Università di Napoli e ordinò che fosse quello il centro degli studi di Medicina. All’epoca in Italia vi erano già altre università, per esempio quella di Bologna, fondata per prima nel 1088, e l’Università di Padova nata nel 1222.
Quest’ultima nacque dalla migrazione di un gruppo di studenti bolognesi. Effettivamente le Università avevano un carattere itinerante, nel senso che gli studenti godevano di ampia libertà di movimento; venivano detti clerici vagantes, perché si spostavano per seguire le lezioni dei docenti che ritenevano più bravi.
Ed essendo chierici godevano anche di alcuni privilegi ecclesiastici.
“C’era anche uno studente di Oxford, che da un bel pezzo aveva finito di almanaccare con la logica. […] Preferiva avere a capo del letto venti libri, rilegati in nero o in rosso, su Aristotele e la sua filosofia, invece di ricchi abiti o un violino o un bel salterio” (Racconti di Canterbury).
Ma attenzione: alla facoltà di Medicina, e quindi al titolo di Dottore, si poteva accedere solo dopo aver studiato le sette Arti Liberali suddivise nel Trivio e nel Quadrivio. Un medico dotto, togato, sapeva parlar bene, scrivere bene e argomentare in maniera logica; ma conosceva anche le stelle, e poiché si pensava che Dio le avesse create e sistemate in quel modo per una ragione, e che i corpi celesti fossero collegati ai corpi terreni, si usavano per aiutare i malati.
Per la cronaca, il padre di Christine de Pizan – la prima scrittrice di professione – fu medico e astrologo del re di Francia Carlo V il Saggio.
Le dissezioni e lo studio dell’Anatomia
Nonostante ai medici si richiedesse una formazione teorica, quasi filosofica, tra la fine del ‘200 e l’inizio del ‘300 diventò sempre più impellente la necessità di sperimentare, di vedere con i propri occhi e di toccare con mano. Si iniziò a studiare seriamente l’Anatomia praticando dissezioni sui corpi umani. La Chiesa non le aveva mai vietate, però, di fronte all’esigenza dei professori di studiare i cadaveri, si è posta il problema del rispetto dei morti; ma la grande spinta del mondo accademico ha fatto sì che si procedesse nella direzione sperimentale. Perciò la Chiesa deliberò che i medici avevano il diritto di praticare le autopsie.
Tra questi medici ricordiamo Mondino de’ Liuzzi (1275-1326), anatomista e professore all’Università di Bologna.
“La donna che ho anatomizzato l’anno scorso, cioè nel 1314 a gennaio, aveva un utero grande il doppio di quella che ho anatomizzato lo stesso anno a marzo. […] L’utero della scrofa che ho anatomizzato nel 1316 era cento volte più grande di quello che ho mai visto in una femmina di umano” (Mondino de’ Liuzzi).
Mondino fu un apripista e in seguito il chirurgo francese Guy de Chauliac (1300-1368) lo definì il caposcuola dell’anatomia umana, avendo egli introdotto la dissezione
E voglio concludere riproponendo un articolo scritto da mia figlia Marina per la rivista Tempo medico sulla mitica Trotula (fig.7), la prima donna ginecologa.
“Dorotea Memoli Apicella nel suo romanzo biografico "Io, Trotula" ricostruisce la figura della celebre medichessa celebrata in tutta l'Europa medioevale per i suoi rimedi ai mali del corpo e dell'anima.
Il sud e la Campania, a fronte di un triste presente, hanno avuto un glorioso passato e non solo Napoli è stata per secoli capitale indiscussa del commercio e delle arti, ma anche Salerno, nell’XI secolo, è stata uno dei centri culturali più importanti del Mediterraneo, dove convergevano i più dotti esponenti del sapere greco, arabo ed ebreo. Tutti conoscono, almeno di nome, la celebre Scuola medica salernitana, la quale si fece promotrice della traduzione in latino dall’arabo di antichi testi, rendendoli così accessibili al mondo occidentale. Era una grande istituzione laica nella quale potevano insegnare docenti di ogni Paese, senza alcuna discriminazione ed anche le donne ne potevano far parte, sia come allieve che come insegnanti. Pochi nomi sono giunti fino a noi di queste laboriose mulieres salernitane e fra queste spicca la figura di Trotula de Ruggiero, nata intorno al 1050, sposa e madre di medici, con i quali collaborò alla stesura di uno dei più famosi manuali di medicina dell’epoca: il Practica brevis. Ma il suo interesse principale era costituito dalle donne, con una particolare attenzione alla gravidanza ed al parto. Il controllo del parto in particolare nei secoli è stato appannaggio ora dell’ uomo ora della donna. Non dimentichiamo la figura chiave della levatrice, che è stata, fino a pochi anni orsono, l’esclusivo punto di riferimento delle donne, non solo in campagna, ma anche in città e ad essa ricorreva in egual misura l’operaia e l’avvocatessa. Trotula de Ruggiero studiò con passione problematiche complesse, che ancora attendono una soluzione definitiva, dalle cause dell’infertilità ai metodi per ridurre i dolori del parto e le gravidanze indesiderate e registrò le sue affascinanti teorie in un libro prezioso: il De passionibus mulierum curandorum, un testo del quale, possiamo scommetterci, nessun ginecologo ha mai sentito parlare.”
Achille della Ragione
 |
| fig. 7 - Trotula De Ruggiero |